Non perdere le novità di Il Blog di Matteo Mazzuca
 Segui gli aggiornamenti del sito: abbonati gratis al feed.
Segui gli aggiornamenti del sito: abbonati gratis al feed.
Gli articoli divisi per argomento
- Cinema 1 articoli
- I miei libri 1 articoli
- Recensioni 31 articoli
Di cosa parliamo sul blog
americano CGI cinema film fotografia luce narrazione regista sceneggiatura Star Wars violenza3 film in 30 righe
Di Matteo @ sabato 8 marzo 2014 - in Recensioni - Commenti (0)
Lone Survivor
 Il regista Peter Berg si era guadagnato la nostra fiducia con Battleship, capace di farci sorridere dei suoi eccessi e dello smaccato patriottismo che lo pervadeva. La visione di Lone Survivor, ambientato in Afghanistan e tratto da una storia vera, era quindi una tappa obbligata. L’epicità, stavolta, non nasce dalla celebrazione della potenza USA, quanto piuttosto dallo spirito di fratellanza che unisce i Navy SEALs. Se il primo atto non riesce a dare spessore ai protagonisti, nei successivi novanta minuti Berg trova finalmente la chiave di volta dei suoi personaggi, che solo nell’azione bellica trovano la loro dimensione più compiuta. Promosso.
Il regista Peter Berg si era guadagnato la nostra fiducia con Battleship, capace di farci sorridere dei suoi eccessi e dello smaccato patriottismo che lo pervadeva. La visione di Lone Survivor, ambientato in Afghanistan e tratto da una storia vera, era quindi una tappa obbligata. L’epicità, stavolta, non nasce dalla celebrazione della potenza USA, quanto piuttosto dallo spirito di fratellanza che unisce i Navy SEALs. Se il primo atto non riesce a dare spessore ai protagonisti, nei successivi novanta minuti Berg trova finalmente la chiave di volta dei suoi personaggi, che solo nell’azione bellica trovano la loro dimensione più compiuta. Promosso.
12 anni schiavo
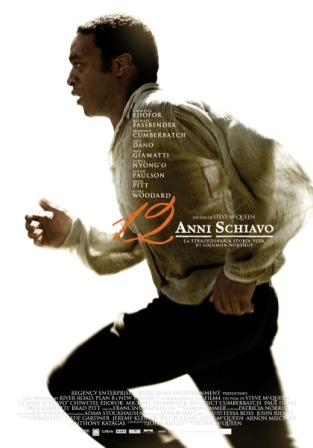 Il problema di un film come 12 anni schiavo è che si porta dietro un carico di aspettative dalla mole pericolosa. Per fortuna dietro la macchina da presa c’è Steve McQueen, con la sua attenzione per i dettagli e per la forza narrativa delle immagini, simboliche o esplicite che siano nella loro espressione (c’è, ad esempio, una plongée capace di evocare una nave negriera da un semplice carro). È il suo sguardo a valorizzare una sceneggiatura premio Oscar ma in realtà piuttosto piatta. Peccato, perché in questo modo il capolavoro di McQueen rimane soltanto uno, Hunger. 12 anni schiavo non va oltre il “molto bello”.
Il problema di un film come 12 anni schiavo è che si porta dietro un carico di aspettative dalla mole pericolosa. Per fortuna dietro la macchina da presa c’è Steve McQueen, con la sua attenzione per i dettagli e per la forza narrativa delle immagini, simboliche o esplicite che siano nella loro espressione (c’è, ad esempio, una plongée capace di evocare una nave negriera da un semplice carro). È il suo sguardo a valorizzare una sceneggiatura premio Oscar ma in realtà piuttosto piatta. Peccato, perché in questo modo il capolavoro di McQueen rimane soltanto uno, Hunger. 12 anni schiavo non va oltre il “molto bello”.
Dallas Buyers Club
Matthew McConaughey (di cui parleremo anche nella recensione su True Detective) ormai da qualche anno ha ri-scoperto di essere un attore. L’Oscar che si è portato a casa insieme a Jared Leto è sacrosanto, perché il film di Jean-Marc Vallée funziona soprattutto grazie alla chimica che si viene a creare tra questi due corpi scarnificati dall’AIDS e drenati di ogni reciproca ipocrisia. Tutto qui? Sì. I corpi essenziali di Dallas Buyers Club sprigionano e rivelano i nuclei ardenti e febbrili del proprio animo, e non è poco. Non è affatto poco.
 film, Battleship, Afghanistan, USA, sceneggiatura, Oscar, Hunger, matthew mconaughey, jean-marc vallee, steve mcqueen, peter berg, jared leto, mark wahlberg
film, Battleship, Afghanistan, USA, sceneggiatura, Oscar, Hunger, matthew mconaughey, jean-marc vallee, steve mcqueen, peter berg, jared leto, mark wahlberg
The Wolf of Wall Street, i lupi siamo noi
Di Matteo @ sabato 25 gennaio 2014 - in Recensioni - Commenti (0)
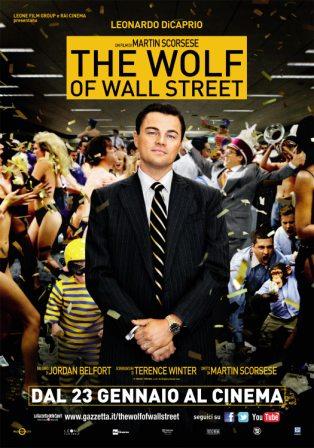 Martin Scorsese si arrende. E vince.
Martin Scorsese si arrende. E vince.
Si arrende alla scalata vuota e spensierata di Jordan Belfort, fatta di tanto sesso, tanta droga e tanti soldi, senza esaltarla né condannarla. Vince perché capisce che Belfort non è l'unico colpevole e punta il dito contro i più insospettabili (chi? Ve lo diciamo alla fine). Capisce anche che del personaggio in sé non c’è davvero molto da dire, si possono solo mostrare la famelica ambizione e gli esiti farseschi, eccessivi e degenerati.
Il giudizio morale sul truffaldino broker spetta a chi si trova al di là della quarta parete, a quel pubblico cui spesso, beffardo e provocatorio, si rivolge un DiCaprio folle e travolgente, che dopo Il Grande Gatsby e Django Unchained corona con The Wolf of Wall Street quella che ha definito come la sua personale trilogia su potere e ricchezza.
Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), quando entra alla Rotschild, la sua prima agenzia, non è ancora il lupo che imperverserà per i seguenti 180 minuti (sì, tre ore, perché il vuoto è fatto di eccessi e di accumulo). Lo trasforma Matthew McConaughey, capace di prendersi tutta la scena in una manciata di minuti, mentore perverso che, novello Dante, conduce il giovane Belfort nell’inferno del brokeraggio (la metafora è di DiCaprio stesso).
È un vortice, la finanza, un gorgo che risucchia chi ci mette piede e ne accetta le non-regole. Ha i suoi maestri e tanti aspiranti discepoli disposti ad ascoltare. Non è un caso che Belfort venga rappresentato come un abile oratore, un santone che parla simultaneamente ai suoi dipendenti e, come già detto, a noi del pubblico, ascoltatori complici. E di proseliti ne fa parecchi.
Chi guarda il film, infatti, fino al momento della caduta (poco rumorosa perché vuota tanto quanto la scalata che l’ha preceduta) non fa altro che divertirsi, complice l'impeccabile montaggio della sempre infallibile Thelma Schoonmaker, tra risate e sorrisi indirizzati a Belfort e al suo team capitanato da Jonah Hill.
Scorsese a questo punto potrebbe chiudere il film sui campi da tennis, e relegare il film al limbo dei compiaciuti divertissement stilistici. Invece sceglie di riprendere, per un'ultima volta, la metafora del predicatore e del suo pubblico.
E con una sola inquadratura ribalta tutto. Fissa il suo sguardo su un gruppo di persone che pendono dalle labbra di Belfort, come tanti piccoli lupi in potenza.
Quando ci accorgiamo che quei volti sono volti comuni, come i nostri, è ormai troppo tardi. Lo schermo è diventato uno specchio, e le persone che vediamo sono solo un riflesso, il nostro riflesso.
Quel pubblico siamo noi. E noi siamo i lupi.

Nebraska, tutti i colori dell'on the road
Di Matteo @ giovedý 23 gennaio 2014 - in Recensioni - Commenti (0)
.jpg) Che cos’è l’America? L’America è un vecchio derelitto e alcolizzato che si trascina per le stesse strade da cui è sorta, è una vana corsa verso orizzonti già esplorati sorretta dalla senile illusione di trovarvi, ancora e dopo tanti anni, un milione di dollari.
Che cos’è l’America? L’America è un vecchio derelitto e alcolizzato che si trascina per le stesse strade da cui è sorta, è una vana corsa verso orizzonti già esplorati sorretta dalla senile illusione di trovarvi, ancora e dopo tanti anni, un milione di dollari.
L’America è il Nebraska dell’ultimo, omonimo film di Alexander Payne, fotografato da Phedon Papamichael in un bianco e nero capace di narrare la crisi dei nostri giorni e di evocare al contempo la Grande Depressione, con un parallelismo in apparenza banale, ma mai didascalico.
Ma Nebraska come mette in scena tutto questo? Con la più classica storia di padri e figli, dove gli ultimi si accorgono solo alla fine di non aver mai conosciuto davvero i primi. La performance di Bruce Dern, nei panni dell’anziano Woody Grant, è fatta di sguardi che, lungi dal perdersi nel vuoto, si astraggono dal presente per fissarsi su orizzonti che, per noi come per il figlio David, è possibile osservare solo dopo aver ripercorso le strade perdute del passato.
Nel film di Payne gli anziani sono infatti i veri protagonisti. Dalla moglie di Woody, cattolica e sboccata, ai parenti, vecchi amici/nemici, antiche fiamme, che popolano le strade (e le tombe) della fittizia Hawthorne, cittadina americana di provincia, autentica quanto classica, incline ad accogliere chi torna dopo tanti anni, ma gretta e avida appena se ne presenta l’occasione.
D’altro canto, la nuova generazione di Hawthorne trova i suoi ambasciatori nei cugini di David, rozzi, obesi e ignoranti che, al pari dei loro padri, misurano il valore di un uomo solo sulla distanza che è capace di divorare in ventiquattro ore, perfetti pronipoti della sfrenate corse all’oro ottocentesche, ma ormai senza senso, quale che sia il punto cardinale di riferimento.
Nebraska è un film riuscito perché non tradisce il cuore dell'on the road, dove gli sterminati spazi del mondo non fanno altro che amplificare le vibrazioni nascoste dell'animo. Ma Payne non si accontenta, e ci aggiunge del suo. Grazie agli strumenti della commedia intima e amara, illuminata spesso da sorrisi malinconici, quasi in tonalità di grigio, tratteggia con pochi tratti numerosi personaggi, tutti riusciti. E il film diventa grande.
Quasi grandissimo.
 Nebraska, film, commedia, bruce dern, alexander payne, bob odenkirk
Nebraska, film, commedia, bruce dern, alexander payne, bob odenkirk
